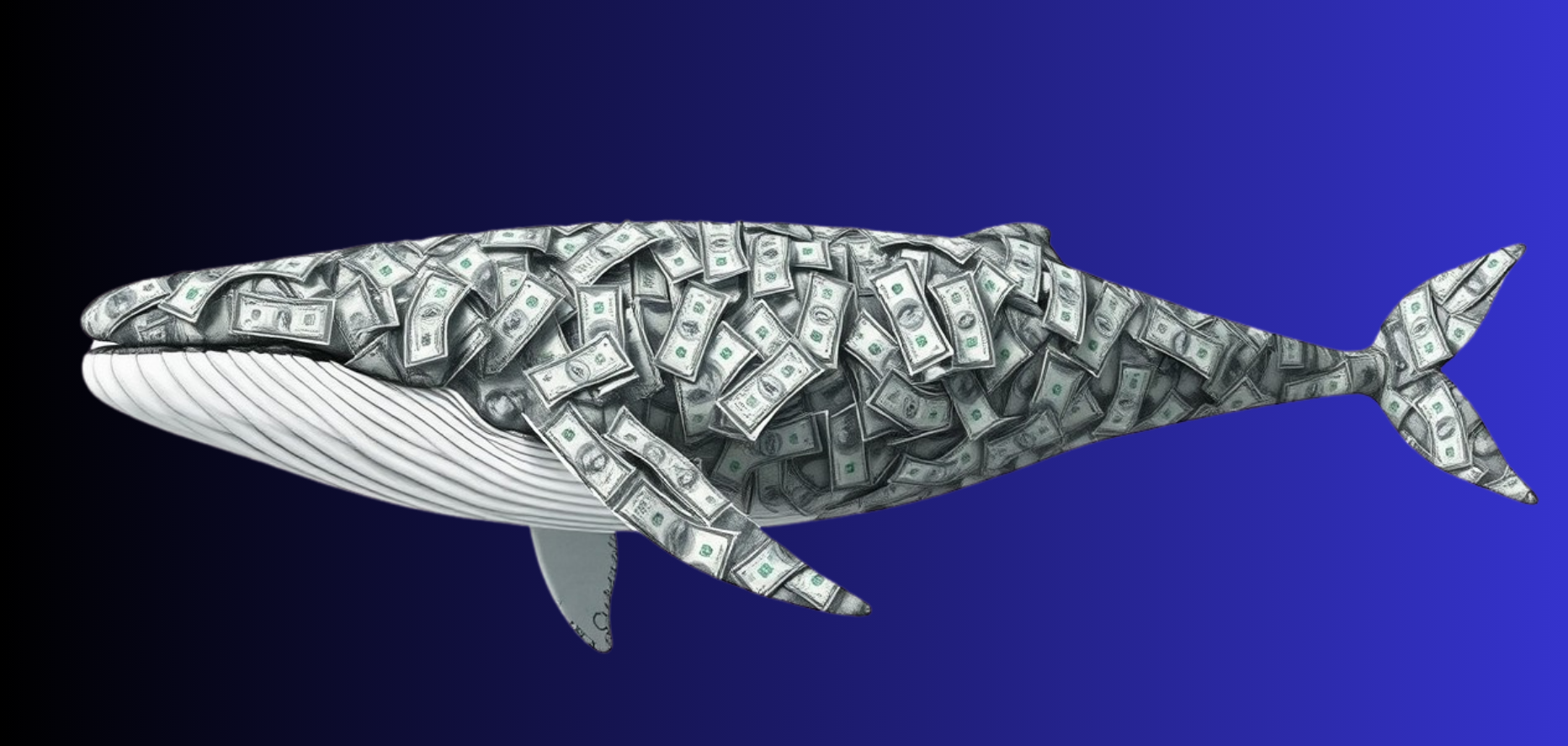“Quanto vale una balena”: la trappola del capitalismo verde
;“Quanto vale una balena” è stato nominato uno dei “Migliori nuovi libri sul clima” dal «Financial Times» e il miglior libro WIRED del 2022. L’intervista all’autrice Adrienne Buller
“Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha prodotto”, diceva Albert Einstein. Eppure è esattamente questo il tentativo del capitalismo verde, secondo Adrienne Buller, autrice di Quanto vale una balena (Add Editore, 2024) e direttrice di ricerca del think tank britannico Common Wealth.
L’approccio economico con cui abbiamo modellato la nostra società fa sì che l’attribuzione di un prezzo sia l’unico modo per comprendere il valore di qualcosa e quindi tutelarlo. Come dice Buller, “la filosofia di fondo del capitalismo verde è: ‘possiamo cambiare tutto, tranne la struttura delle nostre economie e delle nostre società’”, ma abbiamo bisogno di pensare in maniera diametralmente opposta, perché questo approccio, oltre ad essere antiscientifico, è destinato a portarci dritto contro un muro. Di seguito una versione compressa dell’intervista a Adrienne Buller fatta per RBE Radio TV, partner di ènostra, da Alessio Lerda, che potete trovare nella sua interezza in questo video.
Partiamo dal titolo… perché “Quanto vale una balena”?
Ho preso ispirazione da uno studio del Fondo Monetario Internazionale che si chiedeva come fosse possibile migliorare la salvaguardia delle balene. La risposta a cui sono arrivati è che occorreva capire quanto fossero preziose per l’economia, come giustificazione per la loro conservazione. Così hanno stimato la cifra di circa 2 milioni di dollari per balena, in base ad elementi come il turismo o il loro ruolo nell’assorbimento del carbonio.
Penso che questo studio colga bene il tema del libro, ovvero il fatto che il nostro modello economico interpreti la crisi climatica e riesca ad affrontarla solo attraverso il prisma del denaro. Se qualcosa non ha un prezzo, non riusciamo a capire il suo valore e quindi non riusciamo a proteggerlo.
Come siamo arrivati a questo punto?
La risposta semplice è che tutti noi abbiamo vissuto la nostra intera vita in un sistema capitalistico, perciò siamo abituati a pensare che tutto sia mediato dal mercato, perché è così che funziona, o almeno è così che ci viene detto. E questo è il punto di partenza dei legislatori anche nelle politiche climatiche e ambientali: abbiamo bisogno di far funzionare le cose attraverso il mercato, in modo che il settore privato ne tragga profitto.
Prendiamo ad esempio il sistema energetico. Nel Regno Unito, dove vivo, quando si parla di nazionalizzazione dell’energia si scatenano forti reazioni perché è molto radicato il timore del “grande stato” che interviene. Ma penso che nel dibattito manchi la consapevolezza del ruolo importante che il pubblico ha già adesso: come in tanti paesi europei e negli USA, lo stato sovvenziona il settore privato per spingerlo a fare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Perché, appunto, la posizione di partenza è che occorre partire dal mercato, e quindi bisogna trovare un modo per costringerlo a fare quello che vogliamo.
Ma siamo quindi ormai molto lontani dal concetto idealizzato di mercato libero. Qualcuno la descrive come “boscaglia burocratica”, in cui sono coinvolti molti strumenti, regole, supporto pubblico, sussidi e regolamenti, tutto per cercare di far funzionare i mercati e governare questi cambiamenti tramite il profitto. Ma semplicemente non funziona.
Quali sono le più gravi conseguenze di questo tipo di approccio?
Partiamo da un presupposto: l’economia ambientale mainstream è una disciplina che elabora modelli per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico sull’economia. Però non si chiede, al contrario, quale sia la responsabilità dell’economia nello scatenare questa crisi.
Ad esempio, forse non tutti sanno che l’obiettivo dei 2 gradi centigradi al centro dell’Accordo di Parigi deriva da uno studio del celebre economista William Nordhaus risalente al 1975, in cui l’autore individua questa soglia come l’aumento ottimale di temperatura. L’idea sottostante è che le politiche climatiche siano dannose per l’economia e che perciò occorra soppesare quale danno possiamo sopportare.
Il problema è che questo modello economico viene presentato come oggettivo, scientifico, quando in realtà non è affatto così: com’è possibile che il modello di Nordhaus – peraltro insignito del premio Nobel per l’economia – ci indica un aumento fino a 3,4 o 5 gradi come ottimale a livello economico, se la stragrande maggioranza degli scienziati ci dice che questo aumento avrebbe conseguenze catastrofiche per il nostro futuro?
Nel libro sollevi alcuni importanti aspetti problematici del carbon pricing, ovvero il sistema che mette un prezzo ai gas serra con l’obiettivo di ridurne le emissioni. Ce ne parli?
Il carbon pricing è lo strumento politico ideale per l’economia mainstream. Si basa su un principio che suona ragionevole: chi inquina deve pagare. Purtroppo, ancora una volta è un’idea che funziona bene a livello astratto, ma non appena provi ad applicarla incontri ogni sorta di problema.
In primis, non è neanche stato trovato un accordo sul prezzo che dovrebbe avere il carbonio. Nell’ambito dell’economia mainstream si oscilla tra i 40 dollari per tonnellata fino a 14mila dollari, a seconda delle priorità e dei rischi che siamo disposti a correre.
Ma nella realtà, la media attuale del prezzo del carbonio è attorno a 2,5 euro a tonnellata, quindi nemmeno lontanamente vicino alla stima più bassa ipotizzata dagli economisti. C’è un problema alla base: tutte le emissioni vengono trattate allo stesso modo, finendo per sobbarcare il grosso del costo iniziale su tutti noi, quindi per lo più normali persone che lavorano.
Ma trattare ogni unità di carbonio allo stesso modo ignora il fatto che molte delle emissioni che creiamo attualmente sono necessarie ed utili alla nostra sopravvivenza. Invece molte altre sono eccessive e inutili, e sono quelle che dovremmo tassare per eliminarle.
Ma ciò che deve arrivare prima di tutto questo è un intenso investimento nelle alternative. Penso sia questa la grande falla di un prezzo al carbonio, soprattutto se è applicata ad ogni attività allo stesso modo.
Come usciamo da tutto questo?
Quello che ripeto più volte all’interno del libro è che dobbiamo porre al centro di ogni politica la questione della disuguaglianza e della giustizia. E non è qualcosa che dico soltanto per suonare etica e virtuosa, perché è assolutamente necessario anche da un punto di vista pratico. La crisi ambientale e climatica, fondamentalmente, è una crisi di disuguaglianza, e se non affrontiamo il fatto che una piccola frazione della popolazione globale è responsabile di una proporzione enorme di emissioni e di degradazione ambientale, oltre allo sfruttamento di risorse, non arriviamo al nocciolo della questione.